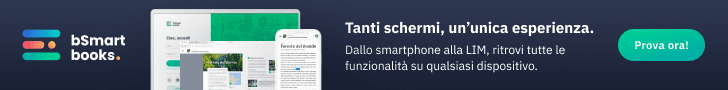Se leggi questo blog da un po’ di tempo, ormai conosci già questa rubrica. Se è la prima volta che capiti da queste parti, benvenuto o benvenuta!
Da alcuni mesi approfondiamo le metodologie didattiche innovative, quelle cioè che si affiancano alla classica lezione frontale e che possono essere utilizzate per rinovare e ampliare le modalità di coinvolgimento della tua classe. Nello scorso articolo della serie abbiamo esplorato l’approccio dell’interdisciplinarità.
In questo articolo, invece, ci focalizziamo sul “Circle Time”. Immagina una classe dove gli alunni, insieme al docente, abbandonano la tradizionale disposizione a file di banchi e si siedono in cerchio: tutti allo stesso livello, sguardi che si incrociano, nessuno escluso. Questo semplice cambiamento può trasformare il clima della classe, favorendo ascolto reciproco, partecipazione attiva e un senso di comunità. Se sei un docente in cerca di strumenti efficaci per migliorare la comunicazione e l’inclusione nel tuo gruppo classe, continua a leggere: scopriremo in cosa consiste la metodologia didattica del Circle Time, quali obiettivi si pone e come puoi applicarla in pratica nei diversi gradi scolastici, con o senza supporto tecnologico. I benefici per te e i tuoi studenti potrebbero sorprenderti!
Cos’è la metodologia didattica del Circle Time e quali sono le sue origini
Il Circle Time (letteralmente “tempo del cerchio”) è un approccio educativo in cui tutti i componenti della classe, insegnante incluso, si dispongono in cerchio per discutere insieme di un argomento o di un problema proposto. Questa disposizione circolare elimina le tradizionali barriere gerarchiche tra docente e alunni: l’insegnante si mette allo stesso livello degli studenti, favorendo un clima paritario e inclusivo in cui ognuno può avere l’attenzione di tutti. Durante il Circle Time vige una comunicazione “a turno” regolata da semplici regole condivise (ad esempio, si può utilizzare un oggetto simbolico che passa di mano in mano e dà la parola a chi lo tiene). Non si tratta di una lezione frontale né di verificare nozioni, bensì di condivisione senza giudizio: ogni partecipante è libero di esprimere opinioni, emozioni ed esperienze, mentre gli altri praticano l’ascolto attivo in un clima di rispetto reciproco.
Origini. Il Circle Time affonda le sue radici negli anni ’70, quando venne studiato e formalizzato nell’ambito della psicologia umanistica da studiosi come Abraham Maslow e Carl Rogers. L’idea di base – cioè il confronto democratico in cerchio – era già presente in forme spontanee nei decenni precedenti, ad esempio in contesti come i gruppi scout o le comunità educative estive, ma è negli anni Settanta che assume dignità pedagogica e metodologica. Da allora il Circle Time si è diffuso come metodologia didattica flessibile e trasversale: oggi è impiegato nelle scuole italiane di ogni ordine e grado – dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria – adattandosi alle diverse età degli studenti. La sua efficacia nel favorire lo sviluppo socio-emotivo e comunicativo del gruppo classe ne ha fatto uno strumento prezioso non solo a scuola, ma talvolta anche in contesti extra-scolastici (formazione aziendale, attività di team building, ecc.).
Quali obbiettivi didattici puoi raggiungere con il Circle Time?
Quali finalità educative persegue il Circle Time? Come molte attività pedagogiche centrate sugli studenti, anche questa metodologia contribuisce a formare i “cittadini di domani” sotto la guida attenta (ma non giudicante) dell’insegnante. L’obiettivo primario è sviluppare atteggiamenti positivi nel gruppo e far progredire la classe verso una maggiore coesione e consapevolezza collettiva. In particolare, attraverso il Circle Time ci si propone di:
-
Acquisire consapevolezza su tematiche sociali (anche delicate) – discutere apertamente argomenti come le differenze, il rispetto, i problemi di convivenza aiuta i ragazzi a sviluppare sensibilità e coscienza civica.
-
Migliorare le abilità di comunicazione e ascolto attivo – grazie ad attività cooperative e dialogiche che coinvolgono sia gli studenti sia l’insegnante, tutti imparano a esprimersi meglio e ad ascoltare i pari con attenzione.
-
Favorire un clima di classe sereno e inclusivo – una discussione ben moderata in cerchio incentiva un’atmosfera rilassata in cui ciascuno sviluppa la propria individualità sentendosi a proprio agio nel gruppo.
Inoltre, dal Circle Time emerge una comunità di giovani capaci di rispettare le regole condivise e di ascoltare le opinioni altrui senza imporre il proprio punto di vista, acquisendo gli strumenti per gestire e risolvere i conflitti attraverso il dialogo costruttivo. In sintesi, l’obiettivo fondamentale è imparare ad ascoltare gli altri evitando derisioni o atteggiamenti aggressivi. Allo stesso tempo, questa pratica spinge gli studenti ad esprimere i propri stati d’animo legati a eventi particolari e a riconoscersi nelle esperienze altrui, traendo insegnamento dai vissuti condivisi. Si sviluppano così empatia e comprensione reciproca, tasselli essenziali della crescita personale e sociale di ogni studente.
Applicazioni pratiche del Circle Time nei diversi livelli scolastici
Una delle caratteristiche più interessanti del Circle Time è la sua versatilità: può essere applicato in vari contesti disciplinari e adattato all’età degli allievi. Di seguito vediamo come utilizzare il Circle Time con attività concrete nei principali livelli scolastici, dalla primaria alle secondarie di primo e secondo grado. In ogni caso, il denominatore comune è creare uno spazio e un tempo dedicati al dialogo, all’ascolto e alla partecipazione attiva di tutti gli studenti, seppur con modalità calibrate sull’età.
Scuola primaria

Nella scuola primaria (e persino dell’infanzia) il Circle Time viene spesso introdotto per facilitare la socializzazione e l’espressione delle emozioni sin da piccoli. Molte scuole dell’infanzia e primarie sperimentano con successo il “tempo del cerchio”, proprio perché anche i bambini di 5–10 anni possono trarne grande beneficio in termini di inclusione e sviluppo di competenze relazionali. In questo contesto, il Circle Time assume spesso la forma di un rituale settimanale (o quotidiano) di classe: ci si può sedere tutti per terra su un tappeto, oppure su sedioline disposte in cerchio, in un ambiente confortevole e informale. Il docente funge da guida e i bambini si abituano gradualmente alle regole base: non interrompere chi parla, rispettare i turni (magari passando un pupazzetto o una palla che “dà la parola”), niente risate o prese in giro dei compagni.
Le attività pratiche di Circle Time alla primaria mirano soprattutto a far emergere la personalità di ogni bambino e a creare un clima di classe positivo. Ad esempio, si possono invitare gli alunni a condividere esperienze semplici e personali: “Qual è stato il momento più bello del tuo weekend?”, oppure “Quale gioco ti piace di più e perché?”. Domande del genere permettono ai più piccoli di esercitarsi a raccontare, mentre i compagni imparano ad ascoltare e fare domande.
Anche temi come i giochi preferiti possono offrire spunti educativi: partendo da ciò che ognuno ama, l’insegnante può guidare una riflessione sugli stereotipi di genere legati ai giochi, aiutando i bambini a superare preconcetti in modo giocoso. Un altro spunto adatto ai più piccoli è parlare di “come mi sento oggi” o “cosa mi rende felice/triste”: il Circle Time diventa così un momento di educazione socio-emotiva in cui i bambini imparano a riconoscere le proprie emozioni e ad ascoltare quelle degli altri in un ambiente protetto.
Infine, il Circle Time alla primaria può essere molto utile per stabilire insieme le regole della classe e coinvolgere tutti nel rispetto reciproco. Ad inizio anno, ad esempio, l’insegnante può dedicare uno o più circle time a discutere con i bambini quali comportamenti rendono la classe un luogo dove “stiamo bene insieme”. Ogni alunno può proporre una regola (alzare la mano prima di parlare, aiutarsi a vicenda, mantenere l’ordine, ecc.), si discute in cerchio e si arriva a una lista condivisa di regole di classe da appendere in aula. Questo processo partecipativo aumenta il senso di responsabilità di ciascun alunno: ogni bambino sente “sua” la regola perché ha contribuito a formularla, ed è più motivato a rispettarla nel quotidiano.
Scuola secondaria di primo grado
Alle medie, il Circle Time assume un ruolo particolarmente prezioso perché gli studenti preadolescenti attraversano una fase di cambiamenti e possono emergere dinamiche di gruppo complesse. In questa fascia d’età il cerchio diventa uno strumento per dare voce ai ragazzi, affrontare temi sociali e prevenire conflitti.
Ad esempio, un insegnante di scuola secondaria di primo grado potrebbe proporre un circle time su argomenti come l’amicizia e l’esclusione, il bullismo, il rispetto delle differenze, oppure più semplicemente offrire agli alunni uno spazio per esprimere problemi di classe. Se ci sono tensioni o episodi conflittuali tra compagni, discutendone insieme in cerchio si può arrivare a soluzioni condivise e a un chiarimento collettivo, evitando interventi punitivi dall’alto da parte del docente.
I ragazzi imparano così a confrontarsi apertamente, a capire il punto di vista altrui e a trovare compromessi, interiorizzando meglio le soluzioni perché frutto del dialogo e non imposte dall’insegnante.

Un’attività pratica tipica per questa età è il “giro di condivisione” su temi personali o scolastici: l’insegnante può chiedere “Quali sono le vostre passioni e interessi fuori da scuola?” oppure “Come vi immaginate tra 10 anni?”. Domande del genere, adeguate a ragazzi di 11–13 anni, stimolano da un lato la riflessione sul futuro e dall’altro fanno emergere talenti e aspirazioni individuali. Condividere in cerchio interessi e sogni aiuta la classe a conoscersi meglio e può offrire al docente spunti per collegare i contenuti didattici agli interessi degli alunni. Un’altra possibile applicazione è nel ripasso metacognitivo: si può dedicare un circle time a fine trimestre chiedendo “Quale lezione o argomento vi ha appassionato di più finora?”.
Oltre a far parlare con entusiasmo i ragazzi, questo fornisce all’insegnante un prezioso feedback per capire quali strategie didattiche hanno funzionato e come tarare il tiro per il futuro. Infine, anche alle medie continua ad essere importante l’aspetto emotivo: un circle time sul tema “che cosa mi fa arrabbiare nel comportamento dei miei compagni e come posso reagire” aiuta i ragazzi a riconoscere le proprie emozioni e a discutere di come gestire rabbia e frustrazione in modo costruttivo.
Queste discussioni guidate favoriscono empatia e coesione nel gruppo proprio in un’età delicata, gettando le basi per un clima positivo negli anni successivi.
Scuola secondaria di secondo grado
Nella scuola superiore l’utilizzo del Circle Time può sembrare meno immediato, poiché gli studenti adolescenti sono abituati a un’impostazione più formale e possono inizialmente mostrare riluttanza a “mettersi in cerchio”. Tuttavia, anche alle superiori questa metodologia può essere adattata con successo – ad esempio con incontri mirati durante l’anno – per sviluppare competenze trasversali e dare spazio alla voce degli studenti più grandi. In un contesto di adolescenti, il Circle Time diventa uno strumento di educazione alla cittadinanza attiva e al pensiero critico. Si possono organizzare cerchi di discussione su temi di attualità (ambiente, legalità, tecnologia e privacy, ecc.), legandoli magari agli argomenti curriculari ma puntando sul dibattito tra pari. In questo caso il docente può assumere il ruolo di moderatore su questioni complesse, stimolando gli studenti ad argomentare le proprie idee e rispettare le opinioni diverse all’interno del gruppo.
Un esempio pratico: nella classe quinta superiore, durante l’ora di Educazione civica, l’insegnante potrebbe proporre un circle time sul tema “libertà di espressione sui social media: pro e contro”. Gli studenti, seduti in cerchio, espongono il proprio punto di vista a turno senza interruzioni, ascoltano attivamente i compagni e replicano in modo rispettoso. Un’attività del genere, oltre a sviluppare competenze oratorie e argomentative, crea un ambiente in cui i ragazzi imparano a dialogare civilmente anche su temi controversi, preparandosi al confronto di idee che troveranno fuori dalla scuola.

Un altro ambito di applicazione alle superiori è quello dell’orientamento e del benessere scolastico. Il Circle Time può essere utilizzato, ad esempio, dal docente coordinatore di classe o dal tutor, per capire come gli studenti vivono l’esperienza scolastica e quali difficoltà incontrano. Incontrarsi periodicamente in cerchio per chiedere “Come va? C’è qualcosa che vorreste migliorare nella classe o nel metodo di studio?” può far emergere problemi nascosti (calo di motivazione, stress, necessità di supporto su qualche materia) che altrimenti rimarrebbero sopiti. Gli studenti più grandi, sentendosi trattati da adulti in un dialogo aperto, apprezzano la fiducia e spesso forniscono spunti utili per migliorare l’organizzazione della classe.
Allo stesso modo, un circle time può essere dedicato a discutere delle prospettive post-diploma: condividere in gruppo “cosa vorrei fare dopo la maturità” aiuta i ragazzi a chiarirsi le idee e a scoprire interessi comuni, creando magari opportunità di aiutarsi a vicenda (es. chi vuole fare medicina può organizzare gruppi di studio di biologia con i compagni, ecc.).
In breve, se calibrato con sensibilità, anche alle superiori il Circle Time è efficace: fornisce uno spazio di ascolto in un periodo di vita complesso, allena all’empatia e al confronto costruttivo, e può rafforzare il rapporto di fiducia tra studenti e docente. Del resto, l’educazione non è fatta solo di programmi da svolgere, ma anche di crescita personale: il cerchio offre proprio quel momento di riflessione comune che spesso manca nelle classi tradizionali.
Circle Time e strumenti tecnologici: possono essere di supporto?
Una domanda legittima per i docenti nell’era digitale è se – e come – sia possibile integrare i mezzi tecnologici con la metodologia del Circle Time. Le fonti consultate su questa metodologia non approfondiscono esplicitamente l’uso della tecnologia in tale contesto, focalizzandosi maggiormente sugli aspetti relazionali e comunicativi del cerchio. Tuttavia, possiamo fare alcune considerazioni pratiche al riguardo.
In linea di principio, il Circle Time è nato come attività analogica e “offline”, basata sul contatto umano diretto: proprio il fatto di guardarsi negli occhi, parlarsi senza intermediari e condividere uno spazio comune è parte integrante del suo valore educativo. Ciò non significa che la tecnologia sia incompatibile, ma ogni strumento digitale va usato con criterio, per potenziare (e non snaturare) gli obiettivi del cerchio.
Ad esempio, in situazioni di didattica a distanza o di classe virtuale, è possibile svolgere un Circle Time online: le piattaforme di videoconferenza (come Google Meet, o Zoom) offrono funzionalità come il “cambio di turno” (alzata di mano virtuale) e la possibilità di vedere tutti i partecipanti in una griglia (che, se non è un vero cerchio, quantomeno visualizza tutti alla pari). In questo caso il docente deve stabilire regole ancora più chiare per gli interventi (magari utilizzando la funzione mute/unmute per dare la parola a turno) e garantire che ciascuno abbia spazio per parlare. Non sarà mai esattamente la stessa cosa che trovarsi fisicamente in cerchio, ma in situazioni particolari, la tecnologia può mantenere viva la pratica del Circle Time, offrendo continuità al dialogo inclusivo.

Anche in presenza, alcuni strumenti tecnologici possono supportare il Circle Time in vari modi. Un esempio è l’uso di applicazioni per raccogliere in anticipo gli spunti di discussione: il docente potrebbe creare una semplice “scatola delle idee” digitale (tramite un form online o una bacheca virtuale tipo Padlet) dove gli studenti, in forma anonima o nominativa, inseriscono proposte di argomenti da trattare nel prossimo circle time.
Questo può incoraggiare soprattutto i più timidi a suggerire temi a loro cari, superando l’eventuale imbarazzo iniziale. Durante la sessione in cerchio, la tecnologia può anche servire per documentare quanto emerso: ad esempio si potrebbe nominare uno studente “segretario” che prende appunti collaborativi su un tablet o alla LIM, creando un breve verbale condiviso (le decisioni prese, le idee chiave, le soluzioni proposte). In tal modo si valorizzano le conclusioni raggiunte dal gruppo e si può ripartire da esse negli incontri successivi.
Un altro possibile supporto tech riguarda la gestione del tempo e dei turni: esistono app-timer o semplici cronometri proiettati alla lavagna che aiutano a tenere i 20–30 minuti entro il limite concordato e magari a segnalare in modo neutrale quando è ora di passare la parola (alcuni docenti usano clessidre digitali o suoni soft come un gong di sottofondo). Questi accorgimenti tecnologici, se usati correttamente, possono rendere il Circle Time più ordinato senza che sia il docente ogni volta a intervenire.
Detto questo, è importante sottolineare che la tecnologia deve rimanere un mezzo, non il fine. Il cuore del Circle Time è la relazione umana: attenzione, empatia, ascolto e parola. Gli strumenti digitali non devono distrarre da questi obiettivi.
Che ruolo ha il docente durante il Circle Time?

Nel Circle Time il docente assume un ruolo molto diverso dalla lezione tradizionale frontale: non è un oratore che spiega, ma un facilitatore e moderatore della comunicazione all’interno del gruppo. Ciò non significa che la figura dell’insegnante passi in secondo piano – al contrario, la sua regia attenta è fondamentale per il buon esito dell’attività – ma questa si esercita in modo più sottile, creando le condizioni perché ciascuno partecipi. In pratica, quali sono i compiti del docente in un Circle Time? Possiamo distinguerne diverse fasi:
-
Preparare l’ambiente e le regole: l’insegnante organizza lo spazio dell’aula disponendo le sedie in cerchio e concorda con la classe quando e per quanto tempo svolgere il Circle Time (20–30 minuti di solito sono sufficienti). Propone anche il metodo per scegliere l’argomento della discussione: ad esempio raccogliendo idee dagli studenti (con un “giro” di proposte o con una scatola delle proposte in cui ognuno può inserire un biglietto) e poi facendo votare quale tema trattare.
-
Avviare e guidare la discussione: durante il Circle Time, il docente siede in cerchio con la classe e avvia la conversazione sul tema scelto. Può iniziare ponendo una domanda stimolo o raccontando brevemente un episodio collegato al tema, per rompere il ghiaccio. Da lì in poi, il suo compito principale è moderare il dibattito in modo non invadente, lasciando che siano gli studenti i veri protagonisti del dialogo. In concreto, l’insegnante dà la parola a turno (ad esempio facilitando il passaggio dell’“oggetto della parola” da uno studente all’altro) e garantisce che non ci siano sovrapposizioni di voci. Se qualcuno tende a monopolizzare la conversazione, interviene gentilmente per coinvolgere anche gli altri; al tempo stesso incoraggia i più timidi a contribuire, magari esplicitamente invitandoli a esprimere il loro pensiero quando li vede a proprio agio.
-
Osservare le dinamiche di gruppo: un buon facilitatore ha anche un occhio attento a come avviene la discussione. Mentre si parla, l’insegnante osserva elementi come: chi sceglie di sedersi vicino a chi, chi interviene per primo e chi tende a restare in silenzio, se qualcuno mostra disagio (gesti nervosi, sguardo sfuggente) o se il gruppo reagisce in modo particolarmente empatico a un intervento. Tutti questi segnali forniscono indicazioni preziose sulla vita della classe: ad esempio, notare che alcuni alunni non si rivolgono mai la parola se non mediati può suggerire di proporre attività per migliorare la coesione; vedere che uno studente sbadiglia frequentemente potrebbe indicare disinteresse o stanchezza, e così via.
-
Chiudere e rielaborare: verso la fine del Circle Time, l’insegnante ha il compito di sintetizzare quanto emerso. Può fare un breve riepilogo dei punti principali del dialogo (“Oggi abbiamo capito che per molti di voi l’amicizia significa soprattutto fiducia…”) per assicurarsi che tutti abbiano colto il succo. Inoltre, è buona pratica concludere con un giro finale in cui ciascuno può dire come si è sentito durante l’attività, oppure con un proprio “takeaway” – qualcosa che porta via dall’incontro. Il docente infine esprime un riscontro complessivo su come si è svolto il Circle Time, sottolineando gli aspetti positivi: ad esempio lodando il rispetto dei turni, la sincerità che alcuni hanno mostrato, l’ascolto attento tra compagni.
In sintesi, il ruolo del docente nel Circle Time è paragonabile a quello di un regista e mediatore: crea l’ambiente giusto, guida senza imporsi, tutela il rispetto delle regole e delle persone, e aiuta il gruppo a riflettere su ciò che fa. Si tratta di una posizione attiva ma non autoritaria. Nei rari casi in cui durante il circle emergano conflitti accesi tra studenti, l’insegnante deve anche fungere da moderatore/mediatore diretto, cercando di far trovare al gruppo una soluzione condivisa e accettabile da tutti, senza schierarsi né imporre il proprio verdetto. Questo richiede abilità di ascolto empatico, neutralità e gestione non violenta delle discussioni – competenze pedagogiche che il Circle Time stesso aiuta a sviluppare col tempo.
Perché scegliere il Circle Time? I vantaggi di questa metodologia didattica
Perché un docente dovrebbe introdurre la metodologia del Circle Time nella propria pratica d’insegnamento? In parte, i benefici li abbiamo già delineati discutendo obiettivi e applicazioni, ma vale la pena riassumere i vantaggi concreti osservati in classi che hanno adottato regolarmente questo approccio.
Il primo aspetto è sicuramente la comunicazione: il Circle Time crea uno spazio in cui parlare e ascoltare diventa più facile. Gli alunni, anche quelli inizialmente più chiusi, col tempo acquisiscono sicurezza nell’esprimersi davanti ai pari, imparano a raccontarsi e a condividere idee senza il timore immediato del giudizio. Questa crescita nelle abilità di comunicazione orale si riflette poi in un migliore rendimento nelle attività scolastiche cooperative e nelle presentazioni orali, oltre che in una maggiore autostima personale.
Un secondo vantaggio tangibile è il miglioramento del clima di classe. L’istituzione di un appuntamento circolare in cui tutti possono portare la propria voce contribuisce a creare un ambiente positivo, di fiducia reciproca. Gli studenti conoscono meglio i propri compagni, scoprendo magari interessi comuni o comprendendo le difficoltà altrui: ciò aumenta la coesione del gruppo e il senso di appartenenza. Spesso diminuiscono i conflitti interpersonali, perché molte incomprensioni vengono “disinnescate” parlandone apertamente nel cerchio.
E quando i conflitti emergono, il Circle Time fornisce gli strumenti per affrontarli in modo costruttivo: gli alunni si esercitano a discutere problemi e trovare soluzioni comuni, sviluppando competenze di problem solving e mediazione dei conflitti. Ciò riduce la necessità di interventi disciplinari dall’alto: la classe diventa più autonoma nel gestire le proprie dinamiche in maniera matura.

Un ulteriore beneficio riguarda l’educazione emotiva e l’empatia. Nel Circle Time gli studenti imparano a riconoscere e verbalizzare le proprie emozioni, così come a mettersi nei panni degli altri ascoltando esperienze diverse dalle proprie. Questo esercizio costante di ascolto empatico li rende più sensibili e rispettosi: col tempo, in classe si nota una maggiore solidarietà verso chi è in difficoltà e un atteggiamento più inclusivo verso le diversità (di opinione, di carattere, di background).
Ad esempio, studenti molto timidi trovano nel cerchio un contesto protetto in cui poter finalmente parlare, mentre compagni più estroversi imparano a moderarsi e a dare spazio agli altri. Si rompe il “guscio” attorno a ciascuno e si crea un gruppo in cui ogni individuo si sente visto e valorizzato per quello che è. Non a caso, il Circle Time è indicato dagli esperti come metodo efficace per promuovere l’inclusione scolastica, in particolare di quegli alunni che rischiano di rimanere ai margini (per difficoltà linguistiche, BES/DSA, timidezza estrema, ecc.).
Dal punto di vista del learning vero e proprio, il Circle Time indirettamente migliora anche l’apprendimento cognitivo. Può sembrare paradossale, dato che durante il circle non si spiegano nuovi contenuti disciplinari, ma uno studente che si sente ascoltato e sereno in classe sarà poi più motivato e ricettivo anche nelle lezioni tradizionali. Inoltre, attraverso le discussioni emergono spesso spunti per rendere più efficace la didattica: ad esempio gli insegnanti, ascoltando cosa ha appassionato o annoiato gli alunni, possono adattare le proprie strategie di conseguenza.
La classe diventa un luogo dove ci si aiuta ad imparare: pensiamo al vantaggio di far raccontare a uno studente come ha risolto un certo problema (magari durante un circle time di matematica), in modo che altri possano apprendere dai pari. Il Circle Time sviluppa insomma competenze trasversali – comunicative, sociali, di pensiero critico – che poi supportano anche le competenze disciplinari.
In conclusione, scegliere la metodologia del Circle Time significa dotarsi di uno strumento pedagogico potente che va oltre la semplice trasmissione di conoscenze: punta a educare persone complete, consapevoli di sé e rispettose degli altri. Gli studenti coinvolti in queste attività mostrano nel tempo una maggiore capacità di riflessione, di gestione delle proprie emozioni e di collaborazione.
Dunque, perché non sedersi in cerchio e dare la parola ai tuoi studenti? Metti in pratica gli spunti presenti in questo articolo e raccontaci come è andata nei commenti!